Del tirannicidio: basi teoretiche, consonanze e contrasti fra le teologie cristiane, quella cattolica occidentale di fra’ Tommaso d’Aquino e quella ortodossa orientale dell’egùmeno Gregorio Palamàs; alcune considerazioni sul tema, dall’antichità al dibattito odierno
Il ridicolo equivoco interpretativo dei concetti proposti da Domenico Quirico su La Stampa di Torino – qualche giorno fa – sul tema del tirannicidio, derivante da una traduzione non so se volutamente scorretta o dalla volontà di cercare un casus belli per litigare con l’Italia, ha convinto l’ambasciatore russo in Italia a denunziare alla Procura di Roma una sorta di incitamento al delitto tramite stampa, quando invece, se il titolo del pezzo ha posto in maniera ipotetica la plausibilità di uccisione del presidente Putin per fermare la guerra di aggressione in Ucraina, il contenuto era chiarissimamente contrario a quella scelta violenta.
Perciò mi pare utile parlarne qui ampliando il discorso ai fondamenti del pensiero teologico e filosofico, sia orientale, sia occidentale.
Partiamo dal termine: tirannicidio deriva dal termine greco tyrànnos.
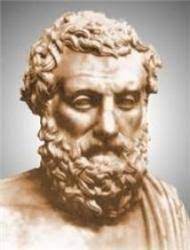
Il termine “tiranno” è di origine greca e significa letteralmente “signore”; Erodoto nelle Storie usa il termine τύραννος (týrannos) (cf. Storie III, 80-82), che vuol dire “signore della città”. In seguito le cose cambiano, anche alla luce del pensiero platonico e aristotelico, che pongono la questione della legittimità del potere e della sua costituzione.
Tiranno è innanzitutto il termine attribuito a qualcuno che conquista il potere e poi lo mantiene in maniera egemonica, in qualche modo dispotica, autarchica, e a volte anche con modalità repressive e violente. Un altro termine pressoché equivalente è “dittatore”. Con il termine “tiranno” nell’antica Grecia dei secoli VII e VI avanti Cristo si definiva chi colui che si impadroniva del potere con modalità rivoluzionarie, opponendosi al sovrano o al politico in carica per tradizione o per elezione. Spesso il nuovo “capo” era sostenuto dal popolo, che soffriva per una gestione del potere precedente divenuta insopportabile.
Il tiranno, dunque, a quei tempi non era un usurpatore tout court, perché talora governava senza stravolgere sostanzialmente le leggi e le istituzioni preesistenti. Inoltre ricopriva personalmente e affidava a suoi fidi le maggiori magistrature, promuoveva lo sviluppo dei commerci, delle opere pubbliche e dell’agricoltura, generalmente nell’interesse del popolo sottomesso ed in contrapposizione ai privilegi dell’aristocrazia. I nomi dei più noti “tiranni” intesi in codesto senso: Policrate di Samo, Clistene di Sicione, Pisistrato di Atene e Dionisio di Siracusa, che chiamò perfino Platone per avere da lui consigli. Storia che non finì molto bene, forse perché i tiranni di tutte le epoche preferiscono gli yesmen, non persone di cultura libera e più vasta della loro. Anche oggi è così.
Si può dire che il tiranno moderno non assomiglia più di tanto a quei tipi di tiranno. L’accezione del termine è molto cambiata nei secoli.
La tirannide come categoria politica e forma di governo è stata trattata nella cultura occidentale, per la prima volta in maniera rigorosa, da Platone nel dialogo Repubblica.
Proprio con il pensiero di Platone e di Aristotele inizia una riflessione sulla tirannide e sulla sua legittimità, laddove il potere del tiranno sia acquisito senza la ricerca di un consenso tra i cittadini, e quindi di una sorta, oggi diremmo, patto costituzionale tra cittadini, ovvero, di contro, sia acquisito a seguito di un processo di corruttela e di scorretto acquisto di consensi.
La tirannide era ritenuta ad Atene un disvalore assoluto e generava paura nei più, timorosi di non avere più la possibilità di discutere dell’esercizio del potere politico, in rappresentanza degli interessi generali. Si tenga sempre presente che gli “interessi generali” di allora non si riferivano a un suffragio universale, bensì al diritto di una significativa… minoranza di capifamiglia possidenti: da questo novero erano esclusi meteci ed iloti, cioè i capifamiglia poveri del contado e le persone pervenute dall’esterno.
Molto interessante è il fatto che il personaggio “tiranno” era oggetto di molta attenzione da parte dei tragediografi, che con il teatro riuscivano a trattare un tema molto arduo e pericoloso per la stessa vita di chi lo trattava.
È proprio sulla scena teatrale infatti che la paura e il disprezzo per il tiranno vengono vissuti con immediatezza, è sulla scena che la tirannide appare sempre meno una soluzione politica e si trasforma in una dimensione umana, in una caratterizzazione di una figura etica e psicologica.
La critica alla figura del tiranno aveva lo scopo di evitare che un singolo cittadino avesse nelle sue mani tutto il potere, dispoticamente. Durante la Guerra del Peloponneso, scoppiata tra Ateniesi e Spartani, il grande Aristofane pronunzia la seguente frase: “Per cinquant’anni non ne ho mai sentito il nome (del tiranno, ndr) e ora va più del pesce conservato.”
Si pensi che l’accusa di tirannide fu formulata anche a Pericle, ed è tutto dire. Tucidide scrive di lui in questo modo: “Era una democrazia a parole, ma di fatto si trattava del potere del primo cittadino“. Erodoto propone una delle prime descrizioni della tirannide (cf. Tripolitikòs lògos ), nella quale si esprime elogiando la democrazia (ovviamente intesa secondo l’idea dei tempi, cf. supra),e criticando la tirannide. Ecco le sue parole: “Come d’altronde il potere di uno solo potrebbe essere cosa conveniente se gli è lecito fare ciò che vuole senza renderne conto? (…) Dai beni che ha a disposizione gli nasce la prepotenza, mentre l’invidia è connaturata all’uomo fin da principio.“
Il tiranno di cui si parla è empio, sfrenato, diffidente e sospettoso, avido, molto simile alla figura che descriverà Platone ne La Repubblica qualche decennio dopo. E’ molto interessante la descrizione erodotea, perché mette in evidenza anche gli aspetti psicologici della “nascita” del tiranno, il quale può anche essere, di per sé, un uomo buono e virtuoso, ma, messo nelle condizioni di esercitare un potere inusitato e grandioso, può cambiare radicalmente diventando arrogante, prepotente, protervo fino all’esercizio della violenza come metodo di agire quotidiano.
Non si possono non riconoscere in questa descrizione i tratti psico-morali dei tiranni che abbiamo storicamente conosciuto nell’ultimo secolo, il XX. La disponibilità di ogni bene e di ogni potere produce in lui la prepotenza (hybris).
Platone, invece, va oltre. Egli vede nel tiranno l’esempio di un essere umano abbandonato dalla razionalità e quindi disponibile ad ogni sorta di eccesso e di agire negativo verso gli altri, i cittadini.
Inoltre, la rappresentazione del tiranno approfondisce anche altri aspetti di questa figura, che sono molto attuali! Si pensi al sentimento della paura, che non solo il tiranno provoca negli altri, ma che egli stesso prova, intuendo di poter in qualsiasi momento perdere la propria posizione ed essere abbattuto, anche perdendo la vita, magari ucciso da chi subisce la sua prepotenza, che può ordire complotti e congiure per liberarsi dal tiranno. Pisistrato e i suoi successori sono gli esempi eponimi della modalità di governo tirannica di quei decenni, in Grecia, una modalità che ha i tratti della tirannide autoreferenziale e finalizzata solo nel suo mantenimento, ma anche i tratti di una tirannide che potremmo definire paleo-populista, perché si opponeva all’aristocrazia dei “migliori” (àristoi) cittadini.
Forse che questo non echeggia qualcosa di contemporaneo? A me ricorda un pochino l’uno vale uno dei grillini, o il vociare scomposto del “salvinismo”. Lo scrivo neppure tanto sommessamente. Grillo (Conte no, perché troppo flaccido) e Bossi/ Salvini potrebbero anche assomigliare a controfigure del tiranno populista.
Aristotele nel V capitolo della Politica individuò tre tipi di tiranno:
- il capopopolo o demagogo, che acquisisce il potere ergendosi a difensore degli umili; (un “salvini”?)
- l’ex magistrato, che fonda il suo potere assoluto partendo da una base istituzionale; (un “di pietro”, meno male che non ce l’ha fatta)
- il monarca o l’oligarca degenerato, che non sopprime ed anzi aumenta i privilegi dell’aristocrazia. (Putin, proprio lui!)
Aristotele ricorda che e prime due tipologie di tiranno furono molto diffuse nella Grecia continentale, mentre la terza invece, molto più rara, si sviluppò solo nelle città dell’Asia Minore, ad esempio i satrapi persiani e poi i diadochi di Alessandro il Grande.
Dimenticavo: nelle situazioni in cui nell’antica Grecia di discuteva di democrazia e tirannide, ebbe anche posto un concetto che cercava di descrivere una forma embrionale di democrazia: l’isonomia, cioè una forma di governo che potesse avvalersi di leggi equilibrate e giuste (ìsos – nòmos).
Infine, solo per completare il lessico di questi temi ricordo un altro modo di dire una figura tirannica o dittatoriale, nella Grecia antica era autarca, dal greco àrkes, comando e àrkein, comandare.
GREGORIO PALAMAS
E ora vengo a Gregorio Palamàs (in greco Γρηγόριος Παλαμάς, Grigòrios Palamàs; 1296-1359), che è stato un monaco cristiano ortodosso, e in seguito arcivescovo.

Monaco del Monte Athos nella Penisola Calcidica, si può definire teologo e mistico, e fece carriera, diventando Arcivescovo di Tessalonica (che è la moderna Salonicco, come è noto ai miei lettori, ma non a diversi politici di alto ruolo e di basso livello).
L’esicasmo, cioè la “preghiera del cuore”, costituisce il fulcro della sua teologia mistica, che egli spiegò approfonditamente nell’opera Filocalia, titolo molto utilizzato tra i teologi dell’Oriente cristiano classico, a partire da Origene. E’ Venerato come santo dalla Chiesa ortodossa (nella cui liturgia la seconda domenica di Quaresima è appunto chiamata Domenica di Gregorio Palamàs), mentre è ricordato liturgicamente nella Chiesa Cattolica Melkita e e nelle Chiese Cattoliche Orientali di rito bizantino in comunione con Roma. La sua festa cade il 14 novembre.
Iniziò i suoi studi di retorica e di filosofia con Teodoro Melchita, manifestando ottime qualità che gli avrebbero potuto aprire una brillante carriera nel funzionariato imperiale (ecco che già qui si può osservare come nell’oriente cristiano si coltivavano i talenti adatti a sostenere il potere civile), ma lui non si sentiva portato, in quanto vedeva nella vita monastica l’ambiente spirituale che sentiva più affine alla sua anima di credente.
Si ritirò, dunque, sul Monte Athos sotto la guida spirituale dell’egumeno (priore) Teolepto, che lo introdusse alla “preghiera del cuore”, di cui l’esempio classico così suona: “Gesù, Figlio di Dio Onnipotente, abbi pietà di me, peccatore“, da ripetersi come le avemarie del rosario e come i novantanove nomi di Allah nell’Islam, in sequenza instancabile, come un mantra buddista. Legàmi sovra-religiosi indubbi.
Gregorio non si è mai ritenuto un pensatore, un filosofo o un teologo in senso accademico. Per lui la cultura ha una sua funzione ma la pratica cristiana e la visione di Dio è qualcosa di assolutamente superiore. Gregorio scrive nella Filocalia:
| «È una conoscenza più alta di quella sulla natura, dell’astronomia e di tutta la filosofia attorno ad esse, non solo sapere Dio e che l’uomo conosca se stesso ed il proprio ordine ma pure che il nostro intelletto sappia la propria debolezza. […] Infatti l’intelletto che conosce la propria debolezza ha trovato anche da dove può giungere la salvezza, avvicinarsi alla luce della conoscenza ed assumere una sapienza vera, che non si dissolve con questo secolo.» |
Commenta scrivendo che avrebbe potuto scrivere in modo retorico per stupire i suoi ascoltatori ma, invece, ha ritenuto opportuno evitarlo. Leggiamo ancora, dalla sua opera citata:
| «La conoscenza della sapienza profana come potrà cacciare fuori dall’anima tutta la malvagità creata dall’ignoranza, se a far questo non basta neppure la conoscenza dell’insegnamento evangelico? […] Neppure la conoscenza del Dio che ha creato queste cose [il mondo visibile e quello invisibile], da sola non può giovare a nessuno. […] Vedi che la sola conoscenza, senza l’amore, non purifica affatto l’anima ma l’uccide. […] L’educazione profana serve alla conoscenza naturale, ma non può mai divenire spirituale, a meno che non accompagni la fede e l’amore di Dio, o meglio ancora, a meno che non sia rigenerata dall’amore e dalla grazia che vi si manifesta.» |
Gregorio fu un grande estimatore di Dionigi l’Areopagita, filosofo e teologo neoplatonico, ma lui non lo scrisse mai, perché non voleva confondersi con i filosofi di professione (potremmo dire, sulle tracce di Agostino, che pure era debitore di Platone in molti concetti filosofico-teologici, come nel concetto di Dio come Bene in-sé), anche se si trattasse di quelli a lui più affini. Leggiamo ancora:
| «[…] con la filosofia i conoscitori della natura e gli scrutatori delle stelle, che si vantano di sapere tutte le cose, non possono accorgersi di nessuna di quelle su elencate [le verità rivelate]. Essi ritennero che il sovrano dell’oscurità intellettuale [il demonio] e tutte le potenze ribelli sotto di lui fossero non solo superiori a loro stessi ma dèi. Li onorarono con dei templi, offrirono dei sacrifici ed assoggettarono se stessi ai loro rovinosissimi oracoli, dai quali ovviamente furono quasi sempre ingannati, attraverso sacerdoti senza sacralità e sudicie purificazioni che ispiravano un’abominevole presunzione, e profeti e profetesse che erravano il più lontano possibile dall’effettiva verità.» |
Gregorio, in questo sulle tracce di Platone (ricordiamo gli agraphà dògmata del grande ateniese, cioè i non-scritti che avrebbero contenuto, anche secondo Aristotele, le idee più alte del Maestro), iniziò a comporre le sue opere quando ne fu costretto. Il suo pensiero si può trarre dagli scritti a difesa del modello di vita monastico e dalle pratiche spirituali dei monaci atòniti (del Monte Athos).
Palamàs, inizia a scrivere anche per contrastare le idee di un monaco-filosofo da poco giunto a Costantinopoli: Barlaam di Calabria.
Barlaam giunse a Costantinopoli apparentemente per motivi di fede, ritenendo che i greci avevano conservato una purezza cristiana persa dai latini. Uno dei suoi primi trattati, infatti, riguarda proprio la difesa di alcune posizioni di fede greche. Appena giunto nella capitale imperiale iniziò ad insegnare filosofia ricevendo attenzione e plauso di un’élite che stava riscoprendo i classici greci. Giunto alle sue orecchie che alcuni monaci facevano strane pratiche d’orazione nel Monte Athos, volle recarvisi per scoprire di cosa si trattava. Nell’Athos, probabilmente, ricevette una pessima spiegazione riguardo a tali pratiche e ne fu scandalizzato. Fece ritorno a Costantinopoli col fermo proposito di denunciare come demoniaco quanto aveva visto. Iniziò subito a diffondere le sue opinioni attirandosi l’attenzione di Palamàs.
Il santo dapprincipio fu mite e consigliò al suo interlocutore di limitarsi alla sola filosofia, tralasciando d’invadere un campo che non era di sua competenza. Barlaam non desistette e, con argomentazioni filosofiche, ripropose le medesime accuse in modo ancor più incisivo e convinto. Solo allora la polemica s’infiammò.
La polemica tra Barlaam e Palamàs ha un interesse che supera di molto il contrasto d’idee tra i due personaggi. Barlaam si può in un certo senso considerare un umanista, il rappresentante di una nuova sensibilità, di un modo nuovo d’osservare il mondo e le idee religiose. Come tale, egli dava un notevole peso alla filosofia neoplatonica (nella quale leggeva in modo particolare lo Pseudo-Dionigi l’Areopagita). Barlaam traccia una netta distinzione tra il regno increato (Dio) e la mente umana in quanto tale. Egli formula una specie d’ “agnosticismo” per quanto riguarda la realtà divina in se stessa.
Ad esempio, siccome per lui, in definitiva, il regno di Dio è inaccessibile all’uomo, non ha senso alcuno il contrasto dogmatico tra Oriente ed Occidente sul Filioque nel campo della conoscenza secolare, pone Platone e Aristotele al più alto livello, al pari della Bibbia e dei Padri della Chiesa per la teologia. Per Barlaam è possibile «conoscere Dio solo attraverso il mondo creato mentre le affermazioni negative su Dio, espresse dallo Pseudo Dionigi, servono unicamente a determinare ciò che Dio non è». Barlaam pensava che, alla fine, lo studio e l’apprendimento fossero più importanti della preghiera e della contemplazionee. Coerentemente con ciò, riteneva una perdita di tempo sottratto allo studio lo stile di vita dei monaci atoniti, completamente incentrato sull’orazione esicasta, ossia su quella preghiera che, includendo particolari tecniche, era fatta nella quiete o “esichìa”.
Barlaam ridicolizzò i monaci esicasti definendoli “omphalompsychoi”, ossia persone che situavano la presenza dell’anima nell’ombelico. Barlaam si oppose agli esicasti, accusandoli d’essere messalianii e cioè di pretendere di vedere l’Essenza Divina con gli occhi del corpo, cosa negata persino da Platone.
Gregorio iniziò col difendere l’esicasmo e passò, in seguito, a ribadire che i profeti hanno un grado di conoscenza del divino che non si può minimamente paragonare a quello di un filosofo, giacché solo i profeti potevano realmente vederLo e sentirLo nel proprio cuore mentre il filosofo Lo poteva solo congetturare. Ciò che l’uomo poteva vedere di Dio non era il Dio in se stesso (la sua sostanza) ma i suoi effetti. Inoltre, l’uomo non può risalire a Dio dalla realtà creata poiché non vi è alcun paragone tra il creato e l’increato (il regno di Dio) (È qui la differente lettura che Palamas e la tradizione orientale hanno dello Pseudo-Dionigi). Non è possibile instaurare tra i due alcun genere d’analogia. Nonostante ciò l’uomo, per grazia, è in grado d’avere esperienza dell’increato e di entrare in comunione con Dio che gli si rivela. Nel sistema palamita è escluso alla radice l'”agnosticismo” barlaamita.
Nelle seguenti parole di Palamàs, in risposta a Barlaam, notiamo la sintesi di alcune sue posizioni che lo oppongono a Barlaam:
| «Non è affatto utile né opportuno, anzi è invece fin troppo dannoso per tutti cercare nelle parole le cose superiori alle parole, gettare i misteri in pasto al popolo, affidare questi temi all’ascolto ed all’intendimento dei bambini, incitare i laici contro i monaci ed offrire motivi di non poca confusione alla Chiesa di Cristo.» |
Queste parole mostrano la profonda differenza nella formazione dei due uomini: il primo, il filosofo Barlaam, aveva grande fiducia nella ragione, che poteva risalire a Dio dalle realtà create. Il secondo, Gregorio, ravvisava nella ragione dei limiti quando si trattava di parlare di Dio, dal momento che Egli è oltre tutto il concepibile e l’umanamente immaginabile. Il primo riteneva utile coinvolgere tutti, il secondo comprendeva che certi argomenti hanno bisogno di prudenza e di profonda formazione spirituale per essere abbordati. Il primo creava una distanza tra il mondo dei laici e quello dei monaci, quasi che questi ultimi fossero il retaggio di un’epoca oramai sorpassata. Il secondo non faceva alcuna differenza tra i due, dal momento che i monaci altro non sono che dei laici i quali vivono radicalmente le esigenze battesimali.
In merito alla questione della possibilità da parte dell’uomo di maturare la conoscenza del Dio trascendente e sostanzialmente inconoscibile, Gregorio distinse fra il conoscere Dio nella sua essenza (in greco ousia) e il conoscere Dio nelle sue “energie” (in greco energeiai), che si possono tradurre con “effetti”, “manifestazioni” o “attività”, per sgombrare il campo da equivoci che le moderne connotazioni esoteriche della parola “energie” possono addurre. Gregorio mantenne la convinzione che fosse impossibile conoscere Dio nella sua essenza (chi sia Dio in e per se stesso), ma mostrò la possibilità di conoscerlo nelle sue “energie” (conoscere che cosa Dio faccia e chi Egli sia in relazione alla creazione e all’uomo), dal momento che Dio si è rivelato nel Figlio suo. Nelle sue argomentazioni Gregorio si rifece ai Padri della Chiesa che lo precedettero, in particolare ai Padri Cappadocii al punto che, per alcuni, compie una geniale sintesi di tutto il pensiero patristico fino ad allora.
Le idee barlaamite furono definitivamente rigettate in due sinodi: uno del giugno e l’altro dell’agosto 1341, entrambi tenuti a Costantinopoli. In seguito alla sua condanna, il Calabro tornò in Italia, fu fatto vescovo di Gerace dal papa e, in seguito, ambasciatore papale a Costantinopoli per preparare un’unione tra la Chiesa greca e quella romana. Le trattative fallirono. Per breve tempo fu pure maestro di greco del Petrarca .
Il pensiero teologico di Gregorio Palamàs è intimamente connesso con l’esperienza cristiana e, quindi, con la mistica. La sua non è teoria o semplice filosofia né, tantomeno, un pensiero di matrice “neoplatonico” come sostengono alcuni. Tra il neoplatonismo e Palamàs c’è quasi un abisso. Palamàs è categorico: solo l’uomo spirituale può essere il trasmettitore di una tradizione spirituale che ha profondi legami con la tradizione dogmatica e ad essa rimanda costantemente. Un uomo che, sulla base della pura logica, presume di farlo conduce fuori strada. Costui viene definito “psichico”, ossia intellettuale. Gregorio ne ha chiara coscienza:
| «Chi si fida dei propri ragionamenti e delle indagini compiute attraverso di essi, perché pensa di trovare tutta la verità con distinzioni, sillogismi ed analisi, non può né conoscere le esperienze dell’uomo spirituale né credere in esse. In effetti costui è psichico: ‘ma chi è psichico’, dice ‘non riceverà le manifestazioni dello Spirito’, né può farlo: quindi chi non le conosce e non vi crede, come potrà renderle conoscibili e credibili, confrontandosi con gli altri? Per questo se uno insegna sulla sobrietà senza esichìa, senza la sobrietà dell’intelletto e senza l’esperienza dei suoi effetti spirituali ed ineffabili, ma invece conformandosi ai propri ragionamenti e cercando in tutti i modi d’indagare con la parola il bene superiore alla parola, è chiaramente caduto in un’estrema follia e, nella sua sapienza, è davvero divenuto pazzo, in quanto ha scioccamente supposto di poter esaminare con una conoscenza naturale le manifestazioni che sono superiori alla natura e le profondità di Dio conosciute solo dallo Spirito.» |
Gregorio Palamàs non ha fatto dei trattati sistematici di teologia, divisi per temi specifici. Quando si trovava davanti ad un problema urgente in cui era richiesta la sua risposta, componeva degli scritti. In questo modo, per risalire alla sua visione dell’uomo, all’antropologia, siamo costretti ad esaminare l’insieme dei suoi scritti. Per Palamàs, l’uomo è una realtà composta di realtà materiali (il corpo) e di realtà spirituali (l’anima e lo spirito). La sua antropologia è strettamente biblica e patristica. Tuttavia, egli quando mostra che l’uomo è fatto per Dio, indica precisamente che ogni sua parte e realtà possono deificarsi, corpo compreso. Palamàs afferma a tal proposito:
| «Il piacere spirituale che dall’intelletto giunge al corpo, per nulla peggiorato per la comunione con il corpo, trasforma il corpo e lo rende spirituale, ed esso respinge i cattivi appetiti carnali e non abbassa più l’anima, ma si solleva con essa, fino al punto che l’uomo intero è Spirito, com’è descritto: ‘Colui che è dello Spirito è Spirito’. Ma tutto questo diventa chiaro solo nell’esperienza.» |
L’uomo non può giungere a Dio con il pensiero razionale (la cosiddetta “dianoia”) ed è per questo che Palamas si oppone a Barlaam. Tuttavia, l’uomo può intuire la presenza divina con la parte più elevata della sua intelligenza intuitiva (il cosiddetto “nouss“). Il “nous” è una specie di “occhio spirituale” che dev’essere purificato per potersi accostare al divino, intravvederlo e goderne. Il “nous”, o intelletto spirituale, dopo essersi staccato da tutti i legami che lo ottenebrano (le passioni e gli attaccamenti mondani) viene calato nel cuore, ossia nella realtà più intima dell’uomo ed è lì che, nella grazia divina, viene deificato e risplende. La preghiera esicasta ha un ruolo importante in questa discesa del “nous” nel cuore. Risplendendo l’occhio interiore, anche tutto il corpo si trova nella luce. In questo senso i monaci esicasti interpretano il famoso versetto del salmo in cui il salmista dice: «E alla tua luce, vediamo la luce» (Sl 35,10).
| «In contrasto con Barlaam, che cercava d’eliminare completamente la passionalità dell’anima [influsso neoplatonico], st. Gregorio Palamas non ha cercato l’annientamento di ciò che è legato al corpo (l’irascibile e il concupiscibile), ma, piuttosto, porlo al servizio del bene e dell’amore.» |
| (Staniloae Dumitru) |
Il santo atonita ha un’antropologia particolarmente dinamica: ha un aspetto legato all’immagine di Cristo, nuovo uomo, e un aspetto trinitario. Riguardo a quest’ultimo, «alla luce della Rivelazione», la natura umana è «natura trinitaria dopo la suprema Trinità, poiché al di sopra di tutte, è fatta a sua immagine, composta da un intelletto (nous), dalla parola (lògos) e dallo spirito (pneuma)». Questo è l’ordine che deve conservare. È in questo che consiste la “bellezza” propria all’uomo preservata «attraverso la fede, la propensione e la disposizione a Lui».
L’antropologia palamita, riprendendo i percorsi classici ascetici dei padri del deserto, è animata da un profondo ottimismo, dal momento che all’uomo è data la possibilità d’essere ontologicamente dio, nella sua Grazia. Palamàs riporta, adattandolo ai suoi tempi, il famoso adagio di Atanasio d’Alessandria in base al quale «Dio si è fatto uomo perché l’uomo si facesse dio».
Questo genere di antropologia ottimista non è molto condiviso in chi si muove con presupposti filosofico-tomistici (qui, infatti, non si parla di “nous”) ed è escluso nei presupposti del pensiero luterano (per i quali l’uomo può essere solo giustificato in quanto inguaribilmente peccatore e quindi distante da Dio).
Per Palamàs la storia della salvezza è un processo in continua realizzazione: Dio opera in ogni istante nel mondo attraverso le sue divine energie. Sono le divine energie che mantengono il mondo in vita, agiscono nell’uomo, lo convertono e lo attraggono a Dio. All’interno di questo quadro generale si situa la vita sacramentale: il fedele nel momento in cui assume i sacramenti (o misteri) partecipa in modo particolare a quelle divine energie che pervadono la realtà. La vita che Dio infonde attraverso l’azione sacramentale procede da Lui stesso e quindi è un atto increato: “Tutte le cose che ci sono state date e concesse in grazia da Dio – dice Gregorio – non sono pari, né ciascuna di esse è una creatura”.
Dio da’ realmente se stesso, non un suo effetto creato, punto che lo divide dalla visione aristotelico-tomista. Inoltre, il misticismo palamita non è sganciato dalla Chiesa, come se fosse un’attività individualistica ma fa parte della storia della salvezza stabilita da Dio nella Chiesa. Il centro di questa storia è Dio stesso che infonde le sue energie all’intero cosmo.
| «[…] grazie alla partecipazione di questo pane divino [quello dell’eucaristia], non solo siamo attaccati, ma anche mescolati al corpo di Cristo, e diveniamo non solo un solo corpo, ma anche un solo spirito con Lui. Vedi che la smisurata grandezza dell’amore di Dio verso di noi interviene e si mostra attraverso la distribuzione di questo pane e di questo vino?.» |
| (Gregorio Palamàs) |
Ma è bene sottolineare che, per lui, i sacramenti non sono e non saranno mai dei fini ma puri mezzi per giungere a Dio. L’asceta che non ha la possibilità di accedervi frequentemente, può comunque purificare se stesso attraverso le “lacrime di penitenza”. Palamàs esorta il suo popolo nei termini seguenti:
| «Quindi, vi prego, non tralasciamo d’invocarLo con digiuni, preghiere, lacrime ed in tutti i modi, finché non ci si avvicini e ci guarisca.» |
| (Gregorio Palamàs, Omelia IX) |
| «Con un intenso dolore e pentimento e con le lacrime, vale a dire con il più drastico farmaco per l’espiazione “Dio non disprezzerà”, dice, “un cuore contrito ed umiliato”; e l’afflizione che piace a Dio attiva un pentimento senza pentimenti per la salvezza, e «colui che semina la sua preghiera nelle lacrime mieterà il perdono nella gioia.» |
| (Gregorio Palamàs, Omelia XXVIII) |
La sua teologia, dunque, pone un accento tutto particolare sul bisogno di purificazione dell’uomo, attività previa e contemporanea a tutto il resto. Una vita sacramentale che prescinda da queste basi finirebbe per rinnegare se stessa. Sembra, perciò, che Palamas conoscesse le critiche che, in tal senso, esprimeva san Simeonee il Nuovo teologo, proprio qualche secolo prima (XI sec.).
| «Ogni prete, diacono e pure monaco, se partecipa alla grazia divina con tutte le condizioni previe stabilite dai Padri, allora è un autentico vescovo, anche se non fosse ancora fatto tale dagli uomini. Al contrario, chiunque non fosse iniziato alla vita spirituale, verrebbe falsamente ordinato, pure se la sua ordinazione lo stabilisse al di sopra degli altri, lo dirigesse e lo facesse comportare in modo arrogante.» |
È solo considerando seriamente questa preminenza carismatica che siamo in grado di comprendere i termini apparentemente “anarchici” dell’ecclesiologia di Palamàs:
| «Poiché, dunque, in Cristo Gesù non c’è né maschio né femmina, né greco né giudeo, ma tutti sono una cosa sola, secondo il divino Apostolo, “così in Lui non c’è né chi comanda, né chi è comandato”, ma tutti, per mezzo della sua grazia, siamo una sola cosa per la fede in Lui, e formiamo il solo corpo della sua Chiesa, avendo Lui come unica testa.» |
| (Gregorio Palamàs, Omelia XV) |
Sempre la preminenza carismatica, che pone l’accento sull’esperienza, fa proclamare, ad esempio, la grazia sacramentale increata (mentre per il tomismo la grazia, pur soprannaturale, è definita “creata” coerentemente con i suoi presupposti filosofici)]. La Chiesa è veramente rappresentata da coloro che hanno esperito tale grazia.
È solo per questo, non per vana erudizione, che Gregorio ama citare le colonne della Chiesa: Dionigi Areopagita, Massimo il Confessore, Basilio Magno, Atanasio di Alessandria, Gregorio di Nissa e altri. Allora, scagliarsi contro i monaci (o ritenerli qualcosa di tutto sommato marginale o poco influente), per Gregorio, non è porsi contro un partito o una parte ma contro la Chiesa stessa poiché essi conservano, vivendolo, il deposito di fede di tutta la Chiesa. Il Tomo Sinodale di condanna a Barlaam, che risente dell’influsso gregoriano, dichiara significativamente:
| «Se qualcun altro manifestasse di muovere contro i monaci una di quelle accuse dette o scritte da lui contro i monaci, “o meglio contro la Chiesa stessa”, o in generale di d’attacarli in tali questioni [sia] sottoposto alla stessa condanna […] anche lui sarà scomunicato e tagliato fuori dalla santa cattolica ed apostolica Chiesa di Cristo e dalla comunità ortodossa dei cristiani.» |
La Chiesa, quale comunità dei santi divinizzati, rappresenta la garanzia del retto cammino. Gregorio afferma:
| «Ho un nugolo di martiri insieme al quale sarò condotto all’incontro col Promesso; ho una squadra di giusti, coi quali otterrò la superiore resurrezione; farò parte della Chiesa con i confessori della fede; sarò nel numero dell’assemblea dei primogeniti; parteciperò di doni ed onori immortali.» |
| (Gregorio Palamàs) |
La funzione sacerdotale, nella Chiesa, ha un ruolo medicinale. Il sacerdote, oltre ad amministrare le medicine della Grazia, ossia i sacramenti, dev’essere in grado di conoscere il cammino che porta a Dio, e precedere i fedeli in esso. In caso contrario, come affermerebbe pure Simeone il Nuovo Teologo, non trasmette il carisma apostolico.
Il suo ruolo non è, dunque, di puro insegnamento ma di testimonianza vivente.
| «Nella sua omelia per il giorno di Pasqua, Gregorio Palamàs esorta ciascun cristiano, dopo aver partecipato alla divina liturgia domenicale, di cercare assiduamente qualcuno che, imitando gli apostoli, rinchiusi il giorno della crocefissione, viva per lo più isolato, nel silenzio con il Signore immerso nella preghiera esicasta e nella salmodia, conducendo una vita irreprensibile. Questo cristiano deve accostarsi a lui, entrare nella sua casetta come se fosse un luogo celeste pieno della potenza santificante dello Spirito Santo […] e interrogarlo su Dio e le cose divine imparandole con umiltà e richiedendo l’aiuto della sua preghiera”.» |
Il concetto monastico e carismatico di Chiesa espresso da Palamas influisce fortemente ancor oggi nell’Oriente cristiano mentre l’Occidente esprime un concetto piuttosto istituzionale e legale.
E’ questo un dilemma etico/giuridico, che ci accompagna fin dall’antichità, col quale si sono cimentati filosofi ed artisti, laici e religiosi, massoni e gesuiti, santi e peccatori, rivoluzionari e lacchè del potere.
DEL TIRANNICIDIO
Da Luciano di Samosata a Cicerone, da S. Tommaso d’Acquino a Lorenzino dei Medici, dalla rivoluzione inglese a quella francese, da Mazzini ai regicidi anarchici, da Tolstoi alle rivoluzioni del XX secolo, e fino ai giorni nostri, non si è mai smesso di ragionare sul tirannicidio, questo gesto di extrema ratio del “diritto di resistenza”.
Ma il tirannicidio è giustificato oppure no ? E’ solo da comprendere o è anche da condividere ? E’ sempre da condannare o dipende dai casi ? Serve a qualcosa o è inutile, o addirittura controproducente ? E’ sufficiente essere eletto dal popolo sovrano per non essere un tiranno o è sufficiente non essere eletto per non diventarlo ?
La dottrina cattolica, ad esempio, distingue tra il “tiranno per usurpazione” (tyrannus in titula, cioè che ha preso il potere illegalmente) ed il “tiranno per oppressione” (tyrannus in regimine, cioè che abusa del potere che ha ricevuto legalmente).
Uno dei riferimenti più datati attribuito a Cicerone che oltre ad affermare che “chi sfugge alla giustizia nei tribunali deve attendersi di trovarla nelle strade” dice anche che “Bellum est in eos qui Judiciis coerceri non possunt” ovvero “facciamo la guerra a coloro contro cui nulla può la legge” .
Ma il riferimento più esplicito sul vero significato del tirannicidio, uno dei testi che meglio spiega se sia lecito o meno uccidere un tiranno, o un dittatore, lo si trova nel Commento alle sentenze di Tommaso d’Aquino (cf. anche mio articolo del 3 marzo u.s.).
Ed è opportuno citare qui uno dei passi più significativi del testo, riferito all’oggetto del nostro approfondimento: “Colui che allo scopo di liberare la patria uccide il tiranno viene lodato e premiato quando il tiranno stesso usurpa il potere con la forza contro il volere dei sudditi, oppure quando i sudditi sono costretti al consenso. E tutto ciò, quando non è possibile il ricorso ad una istanza superiore, costituisce una lode per colui che uccide il tiranno ”.
E quest’ultimo passaggio è spiegato così dal Prof. Aldo Vendemiati : “Se il tiranno è un feudatario, si può ricorrere all’imperatore per rimuoverlo. Ma se non esiste un imperatore, il tiranno va ucciso”.
Questo pensiero va ben oltre rispetto a ciò che scriveva il giurista e filosofo Ugo Grozio nel De Jure belli ac pacis : “Un re che si dichiara apertamente nemico del suo popolo, e che abdica così al suo potere, sia da combattere fino alla fine”.
Qualche anno prima Giovanni di Salisbury , ragionando sul diritto di tirannicidio, affermava che “non soltanto è permesso ma è anche equo e giusto uccidere i tiranni . . . e in quanto immagine di malvagità, il più delle volte va addirittura ucciso” potendosi sostenere il principio fondamentale della difesa sociale e che, per analogia, è “dunque possibile considerare come se fosse una legittima difesa personale ”.
Nel 1414 Claudio Fleury fa la “telecronaca” delle numerose sessioni di una Assemblea tenutasi in Francia a partire dal 30 Novembre, presso l’Università di Parigi, sugli scritti di Giovanni il Piccolo che citava tutti i casi di tirannicidio della Bibbia e sosteneva la tesi che “Ciascun tiranno deve e può essere lodevolmente e per merito ucciso da qualunque suo vassallo e suddito in qualunque forma ”.
E ancora: “E’ lecito a ciascun suddito senza niun mandato o comandamento, secondo la legge morale, naturale, e divina, di uccidere o far uccidere ogni tiranno . . . non solamente è lecito, ma è onorevole, meritorio parimente . . . ”
E sono citate dall’autore una serie di uccisioni a partire da quella di Lucifero a quella di Finees, figlio di Eleazaro, che uccise Zambri, di Giuditta che uccise Oloferne, di Joab che uccise Abner , e molte altre ancora.
Parole forti su questo argomento, sulla necessità di uccidere i tiranni, sono scritte dal gesuita Juan de Mariana nel 1599: “Riteniamo che si debbano tentare tutti i rimedi per rinsavirlo prima di giungere a un punto estremo e gravissimo. Ma se ogni speranza fosse oramai tolta e se fossero in pericolo la salute pubblica e la sanità della religione, chi sarà tanto povero di saggezza da non ammettere che sia lecito abbattere il tiranno con diritto, con le leggi e con le armi ?”
Ed infine non si può non citare quanto scrive Maximilien Robespierre : “Quali sono le leggi che la sostituiscono allora ? (ndr: la Costituzione) Quelle della natura, quella che è alla base della stessa società: la salvezza del popolo. Il diritto di punire il tiranno e quello di deporlo dal trono sono la stessa cosa . . . il processo al tiranno è l’insurrezione, il suo giudizio è la caduta della sua potenza, la sua pena quella che richiede la libertà del popolo”.
Ma è sorprendente ed inaspettato trovare, e leggere, quanto scritto in un documento relativamente recente, nella Costituzione conciliare del 1965 Gaudium et Spes : “Dove i cittadini sono oppressi da un’autorità pubblica che va al di là delle sue competenze, essi non ricusino di fare quelle cose che sono oggettivamente richieste dal bene comune e sia perciò lecito difendere i propri diritti contro gli abusi dell’autorità”. Autore: Paolo VI
Ma in una società complessa, di capitalismo avanzato, può esistere la figura del tiranno oppure il “potere” è spersonalizzato ed ogni membro della classe dirigente può essere subito rimpiazzato ?
Spesso il dibattito si è intrecciato e confuso con quello della lotta armata, la clandestinità, il terrorismo ma se teniamo distinti i due piani, come fece l’Alfieri , possiamo arrivare alla conclusione che, anche se talvolta può esistere una congiura, il tirannicidio, il più delle volte, è frutto di iniziative individuali ed occasionali; rientrano, invece, in una categoria “mista” gli attentati subiti da Luis Carrero Blanco nel 1973 e riuscito, da Anastasio Somoza Debayle nel 1980 e riuscito, da Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nel 1985 e non riuscito.
Di solito il tirannicida va, o vorrebbe andare, a colpo sicuro, ammazza, o cerca di ammazzare, il tiranno o, al minimo, un suo strettissimo collaboratore.
Qualche anno fa il dibattito si è riacceso a proposito della “guerra preventiva” contro l’Iraq; qualcuno ha giustificato l’aggressione e l’invasione con la necessità di eliminare Ṣaddām Ḥusayn ʿAbd al-Majīd al-Tikrītī ; tale interpretazione non è condivisibile perché il tirannicidio, oltre ad avere le caratteristiche sopra specificate, deve essere compiuto “dal basso”, da un suddito, dall’oppresso, comunque da una vittima del tiranno, da qualcuno che ha subito il suo potere.
Di solito si afferma che il “terrorista di oggi è lo statista di domani” .
Per l’impero britannico George Washington era un terrorista, per l’impero austro-ungarico terroristi erano i carbonari e la Giovine Italia, per gli occupanti tedeschi erano terroristi i partigiani, negli anni 1930-1940 Yitzhak Shamir, uno dei padri della patria israeliana, era un terrorista responsabile di attentati anti-arabi ed anti-britannici tra cui, nel novembre del 1944, l’omicidio del rappresentante inglese in Egitto Lord Walter Edward Guinness, barone Moyne.
Per buona parte della sua vita Nelson Mandela è stato definito “terrorista” anche da un leader di governo europeo come Margaret Thatcher.
Allo stesso modo si può dire che il regicida/tirannicida all’inizio viene considerato un “folle” ed un “criminale” per poi essere ricordato come martire, eroe e precursore dei tempi.
A partire dal VI secolo a.C., ad Atene, diverse statue di bronzo celebrarono il tirannicidio compiuto da Armodio e Aristogitone a danno del tiranno Ipparco.
Gaetano Bresci, autore dell’attentato a Umberto I° , è celebrato come eroe e vendicatore dei proletari e viene commemorato da una statua a Carrara .
Sferzante e pieno di tragico realismo è quanto scrive James Connolly : “Per le vie di Milano cento donne della classe operaia vengono uccise con la baionetta o a colpi di arma da fuoco, stringendo al seno i loro bimbi affamati mentre la buona società riserva loro un trafiletto di giornale. Una imperatrice è pugnalata in una strada di Ginevra e, apriti cielo, l’Umanità ne è sconvolta ! Sarà forse l’impietosa mano della storia a rovesciare la procedura dedicando a quell’olocausto di lavoratrici un intero capitolo in quanto martiri dell’umanità e confinando l’assassinio dell’imperatrice in una nota a piè pagina”?
Dissacrante e cinico può essere giudicato quanto scritto da Lenin : “In verità quanto accaduto al re del Portogallo è solo un incidente sul lavoro legato al mestiere di re . . . Da parte nostra ci limitiamo ad aggiungere che una sola cosa ci dispiace: che il movimento repubblicano in Portogallo non abbia regolato i conti con tutti gli avventurieri in modo sufficientemente aperto e deciso”.
E restano distanti e contraddittori i giudizi, la “memoria divisa”, sugli avvenimenti di Piazzale Loreto e sulle diverse versioni e ricostruzione dei fatti che ancora oggi, nonostante i numerosi studi effettuati, restano ancora parzialmente dubbi e nel mistero.
Ed oggi ?
Oggi non esiste più il nuovo principe ma il nuovo despota collettivo, la casta; l’attentato al tiranno di ieri è cosa molto meno complessa della lotta alla casta di oggi, anche perché questa non ha una sola testa, ma mille teste e come una piovra estende i suoi tentacoli in ogni strato della società.
Non basta il complotto o l’atto isolato, ci vuole una complessa opera collettiva, articolata e ben organizzata.
Molto altro si potrebbe scrivere e tanto si potrebbe dibattere su questo argomento, anche riferito alle più quotidiane vicende della nostra vita spicciola e professionale, ovviamente solo metaforicamente e non riferibili a re o tiranni; lo scopo di queste poche righe era quello di offrire lo spunto per ulteriori riflessioni personali anche nell’ambito delle proprie vicissitudini.
Quanto da me scritto in questo saggio non ha la pretesa di costituire un itinerario teorico di verità, ma certamente di documentata riflessione. Ciò mi permette di rispondere a una domanda che mi è stata fatta e che probabilmente può essere nel cuore implicitamente di qualche lettore: “Chi sono quelle persone che ho citato nei vari ruoli per dire, affermare, decidere, etc…?”
E’ semplice: (ha titolo di essere citato in una ricerca scientifia) chi variamente opera nella storia umana, le cui vicende vanno analizzate con acribia e precisione documentale e non ideologicamente. Se si parla di teologia non si può applicare lo statuto epistemologico dell’ateismo militante, proprio perché l’ateismo è una ideologia. Lo statuto epistemologico dell’agnosticismo, invece, non si scontra con l’onestà intellettuale della ricerca. L’ateismo professato con astio, sì.
Concludo: la dottrina cattolica prevede il tirannicidio con chiarezza, quella ortodossa, no. E Putin che cosa è? Un tiranno? Conclusione retorica a una domanda retorica.
Post correlati

0 Comments